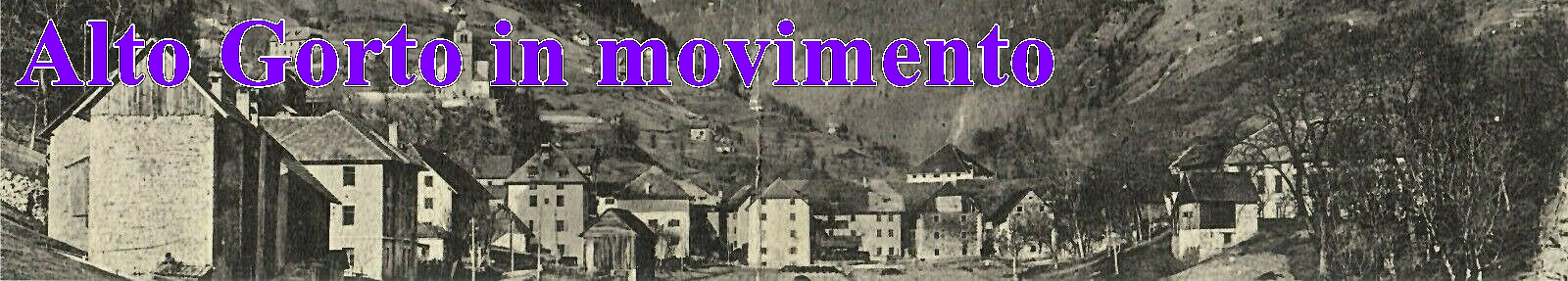Carte del vicariato foraneo di Gorto in Carnia (1270-1497)
Indice dei nomi di persona ordinati per zona, località e data — Tabella scaricabile in formato csv

Gilberto Dell'Oste (a cura di), Carte del vicariato foraneo di Gorto in Carnia (1270-1497), Coordinamento dei circoli culturali della Carnia, s.l., 1999, p. 366, 15,50 € (esaurito).
Premessa
A oltre un ventennio dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 1999, numerosi indizi inducono a ritenere che la circolazione di questo libro di Gilberto dell’Oste abbia travalicato la cerchia ristretta degli specialisti per toccare una platea molto più vasta di lettori.
Si tratta di un risultato non scontato per un’edizione critica di documenti storici antichi, alcuni dei quali sostanzialmente inediti e poco noti «agli stessi studiosi di storia locale».
Il “cuore” del volume è, infatti, costituito dalla «edizione dei documenti più antichi, dal XIII al XV secolo, ancora conservati negli archivi parrocchiali del vicariato foraneo di Gorto o comunque provenienti dagli archivi medesimi» (Tabella 1).
Sono, in tutto, 139 atti, costituenti «un insieme sufficientemente unitario ed omogeneo, riferendosi per lo più allo stato patrimoniale della pieve di Gorto o delle chiese ad essa soggette ed attestandone l'accrescimento nel corso degli anni», provenienti da sei archivi:
- l’archivio della pieve di Santa Maria di Gorto, Luincis (64 documenti);
- l’archivio parrocchiale di Sant’Andrea di Zovello (18);
- l’archivio parrocchiale di San Giacomo di Pesariis (15);
- l’archivio parrocchiale di San Canciano di Prato Carnico (3);
- un archivio privato di Ovaro (21);
- un residuo dell’archivio storico della soppressa Parrocchia di San Leonardo di Osais custodito da una famiglia di Osais (18).
Dal punto di vista “genetico” sono quasi tutti originali «[A] ad eccezione di due copie autentiche (docc. 50, 51) ed una copia semplice (doc. 93) [B]; tra gli originali, inoltre, trentadue documenti sono originali ricavati dalle imbreviature di un altro notaio. Per quanto riguarda il supporto dei documenti, soltanto il citato doc. 93 è cartaceo, mentre gli altri centotrentotto documenti sono conservati su centotrentatré pergamene».
Sezione introduttiva
La parte iniziale del libro contiene un importante studio, articolato in quattro capitoli, che costituisce, ad un tempo, uno strumento di orientamento indispensabile per affrontare la “lettura” della sezione documentaria e una magistrale dimostrazione delle possibilità di lettura della stessa.
Capitolo I
Il primo capitolo, dal titolo La pieve di Gorto e le chiese filiali, si sofferma in particolare sul «processo di segmentazione del territorio plebanale di Gorto» e il «carattere popolare della nascita delle cure e parrocchie in Carnia» connesso all’affermazione di «una classe media costituita da piccoli proprietari, artigiani e commercianti, capace di esprimere i propri interessi entro i consigli delle vicinie».
Superati i tempi oscuri delle origini, collocabili in «epoca paleocristiana», le prime notizie certe sulla pieve si hanno nel sec. XII, durante la «fase di fondazione dell’abbazia di S. Gallo di Moggio, cui il territorio gortano fu soggetto dal tardo medioevo sino in epoca moderna.»
Nel 1270 «si nota la presenza di due vicari che forse avevano già abbandonato la vita comune, Bortolotto da Agrons ed Enrico prete di Ovaro; nel 1305 vi si può documentare l’esistenza di ben tre vicari residenti rispettivamente a Luincis, Ovaro e Comeglians; da queste ville, poste in una posizione centrale del fondovalle, essi dovevano provvedere “in solido” alla cura d’anime di un’area molto vasta comprendente la media e alta Valle del Degano, l’alta Valle del Piave (Sappada), la Val Pesarina e la Val Calda, spingendosi sino a Cercivento, nella Valle del But.»
I documenti editi consentono all’autore di arricchire e integrare le conoscenze acquisite in precedenza dalla ricerca storica; viene, per esempio, provata l’esistenza nel 1295 della chiesa di Santa Margherita di Sappada (che ora primeggia sulle altre filiali quanto ad attestazione di vetustà); anche la notizia sui due vicari di Gorto nel 1270, a cui si è accennato, è una novità assoluta.
Interessante l’esame della documentazione sulla «costruzione delle chiese di S. Caterina di Luint, di S. Leonardo di Osais e della Ss. Trinità presso Lenzone» che mette «in luce quali fossero le forze sociali interessate a favorire il sorgere delle cappelle filiali prima e di nuove cure e parrocchie poi».
Per quanto riguarda la Val Pesarina si viene a conoscenza, per esempio, che «la costruzione - o ricostruzione - della chiesa di S. Leonardo di Osais venne concessa dall’abate di Moggio (9 aprile 1391) in seguito alla supplica rivoltagli da Giovanni del fu Odorico da Osais, in qualità di rappresentante dell'intera comunità del villaggio; poco più tardi gli abitanti di Osais ricevettero dal calzolaio Osaino del fu Bortolo da Solaro di Pesariis, come legato pro remedio anime per l’edificazione della chiesa, un bearzo facente parte di un suo manso sito nel villaggio di Osais».
Una quarantina d'anni dopo, nel 1430, l’abate di Moggio concesse una analoga licenza per la chiesa di San Gottardo di Sostasio. Anche in questo caso la richiesta partì dalla comunità di villaggio, ma rappresentata non da un unico soggetto, bensì da «una delegazione dei capifamiglia costituenti la vicinia di Sostasio: Odorico da Alva, Giacomo Blasutti, Domenico del fu Leonardo da Avausa e Toscano del fu Giovanni da Luc affermano infatti di agire anche a nome dei convicini Giacomo del fu Venerio, Giacomo del fu Domenico, Odorico del fu Guarnerio, Antonio e Stefano del fu Giacomo Blasutoni, Cristoforo e Giacomo del fu Toscano, e Giacomo detto “Pogl”, essendo questo villaggio costituito, come pare, da sole dodici famiglie».
Capitolo II
Il secondo capitolo, intitolato I sacerdoti e l’arcidiaconato, si apre con l’analisi del documento più antico contenuto nell’edizione (doc. n. 1 del 12 novembre 1270) «inspiegabilmente ignoto agli stessi Gortani e Roia, così come a tutti gli studiosi che in seguito si sono occupati della storia di Gorto», riportante la notizia, alla quale si è già accennato, sui due preti officianti nella pieve di Gorto, «Enrico presbiter de Ovaro» e «prete Bortolotto da Agrons vicarius plebis Sancte Marie de Gorto», l’uno abitante ad Ovaro e l’altro probabilmente ad Agrons.
Nel 1295 il testamento di Enrico "Fantulùt" da Comeglians «conferma la presenza di almeno due sacerdoti presso la pieve»; nel 1305 il legato disposto da Giacomo Terencart da Tolmezzo documenta l'esistenza di «tre vicari officianti, rispettivamente, nella matrice, in S. Vigilio di Ovaro e in S. Giorgio di Comeglians, pur conservando tutti il titolo di vicarii et rectores della pieve di S. Maria di Gorto».
Nella prima metà del Trecento si ha «notizia di quattro sacerdoti residenti in altrettanti villaggi, corrispondenti alle sedi delle cure già distintesi entro il territorio plebanale: Carsmanno a Ovaro nel 1318, Assalonne, vicario di S. Giorgio, presso Comeglians nel 1320, Artrusio, probabilmente a Luincis nel 1336, e Giacomo, vicario di S. Canciano, presso Prato Carnico nel 1343».
Tra loro primeggia Assalonne, «impegnato nella duplice attività di prete e notaio per circa trent'anni, dal 1320 al 1348» nonché «vicario dell’abate in archidiaconatu de Gorto» con «facoltà di giudicare in prima istanza certe cause» e probabilmente investito degli «altri diritti arcidiaconali»; le sue tracce si perdono nel 1348, l’anno della «grave epidemia di peste che a quel tempo pare aver raggiunto anche i villaggi gortani».
Come già accennato i vicari operavano ancora «in solidum entro il territorio plebanale, ciascuno recandosi da un villaggio all’altro a seconda della necessità» e ciò valeva probabilmente «anche per il vicario di S. Canciano di Prato Carnico, il cui beneficio era riferito al solo territorio, ben delimitato, della Val Pesarina.»
Nella seconda metà del Trecento si accentua la tendenza all’autonomia delle filiali. La cura di San Giorgio di Comeglians «acquista progressivamente una maggiore autonomia, dal momento che il suo sacerdote non è più tenuto ad officiare stabilmente nella pieve». È questo il periodo in cui si comincia «ad avere qualche indicazione riguardo alla provenienza dei sacerdoti officianti in Gorto, ben pochi dei quali risultano essere carnici: per la maggior parte essi giungono infatti dal Veneto o da altre regioni italiane, ma ve ne sono pure d’Oltralpe, alcuni tedeschi e persino uno francese».
Il fenomeno dei preti forestieri si fa ancora più evidente nel «Quattrocento, proprio quando il giuspatronato popolare viene esercitato in tutte le cure del territorio gortano» e riguarda tutte le cure di Gorto anche se «da ciò non si deve dedurre che vi fosse una totale assenza di ecclesiastici di origine locale, ma piuttosto che questi preferissero, a loro volta, cercare altrove migliori condizioni di vita», forse «sia per i disagi tipici del territorio montano, sia per la particolare condizione della pieve, il cui quartese spettava all'abate di Moggio» rendendo i benefici meno attraenti.
Nella seconda metà del Quattrocento «nascono le cure di Rigolato e Monaio. Anche in queste cure si nota una prevalenza di preti forestieri, ai quali si affiancano anche alcuni di origine locale». Infine, «la serie dei sacerdoti officianti in Gorto nel Quattrocento può dirsi conclusa, emblematicamente, con i due vicari della pieve, i preti Mariano de Lanzano - forse Lanciano, presso Chieti - ed il carnico Daniele di magistro Fortunassio da Lauco, entrambi testimoni ad un contratto stipulato ad Ovaro il 17 agosto 1499, la cui diversa provenienza geografica riassume una situazione ormai ben nota, e del resto riscontrabile anche nei primi decenni del secolo successivo.»
Capitolo III
Il terzo capitolo, intitolato I notai nel Canal di Gorto, si sofferma sui notai operanti tra la fine del Duecento e gli inizi del Cinquecento. Nel primo Trecento i notai di origine locale appaiono già ben radicati a Ovaro, Luincis e Comeglians, località, non a caso, corrispondenti alle «antiche cure soggette alla pieve».
Benché siano attivi anche dei «notai forestieri, provenienti sia da Tolmezzo che da altre località del Friuli, evidentemente richiamati da particolari eventi quali la fiera di S. Martino o le feste locali di alcuni villaggi», almeno dalla seconda metà del Trecento la loro presenza «può dirsi fortuita, restando esclusa - almeno per questo periodo - l’ipotesi di un’effettiva assenza di notai locali».
Il primo notaio autoctono di cui si abbia notizia «è Ulrico da Gorto, probabilmente residente ad Ovaro, dove egli redige il testamento di Enrico “Fantulùt” da Comeglians il 2 agosto 1295». Per esercitare la professione si recava «presso le abitazioni dei propri clienti, o nelle vie pubbliche», come testimoniato dalle «compravendite tenutesi a Ravascletto e Rigolato, rispettivamente nel 1309 e nel 1319» e da quella redatta «il 20 maggio 1308 sulla via pubblica di Comeglians, di fronte alla casa degli acquirenti».
Dal 1310 al 1357 è attivo il «notaio Stefano detto “Guerra” di Ermanno del fu Guarnerio da Luincis, appartenente all’omonima casata feudale»; per lui, probabilmente, il notariato costituiva «un’attività secondaria, quasi occasionale». Due suoi figli, Ermanno e Francescutto, proseguiranno la professione notarile, ma i loro atti non ci sono pervenuti.
Nel periodo 1320-1348 esercita il notariato anche prete Carsmanno, vicario di Ovaro e arcidiacono, che per «svolgere la sua duplice attività si sposta frequentemente tra i vari villaggi del quartiere di Gorto, rogando soprattutto testamenti».
A fine Trecento, per un breve periodo, sono documentati ben quattro notai residenti a Comeglians. Si tratta di «un Giovanni di Leonardo fabbro rogatario nel 1378, e nel 1383 un Nicolò di Leonardo sarto, a conferma della vitalità del ceto medio artigianale, che proprio in questi anni sembra assumere un ruolo di grande importanza entro le comunità di villaggio», e di un «notaio Odorico del fu Diolaiuti che nel 1396 si trova a Tolmezzo tra i testimoni ad una sentenza del gastaldo della Carnia, insieme al notaio Daniele di Giovanni da Comeglians, suo compaesano, ed altri valligiani».
Dal 1370 al 1423 opera il notaio Daniele Carlevariis, figlio di Biagio detto “Carlevario” «cameraro della pieve di Gorto nel 1351 e figlio, a sua volta, dei coniugi Guargendo e Leita da Mignulesco, viventi nei primi decenni del Trecento», nativo di Mignulesco, trasferitosi a Luincis «insieme al fratello Enrico, lasciando un terzo fratello di nome Odorico nel borgo nativo». Il fratello Francesco «esercita l’arte notarile a lungo, almeno sino al 1465, spostandosi frequentemente tra i vari villaggi del basso Canal di Gorto e della Val Pesarina.» La sua famiglia «acquista sempre maggior prestigio sociale, poiché uno dei suoi quattro figli, Daniele Carlevariis, chierico in Aquileia nel 1464, ottiene poi per intercessione del pontefice Pio II un canonicato in Aquileia ed uno in Cividale», e diviene anche preposito dei Ss. Felice e Fortunato di Aquileia e vicario generale sostituto del patriarca.
Nei primi decenni del Quattrocento ci sono tracce di diversi notai provenienti da altre località carniche tra i quali Giovanni da Socchieve (nel 1430 redige a Comeglians la licenza per la costruzione della chiesa di S. Gottardo di Sostasio), Bartolomeo di Giacomo da Sala del Comelico, residente a Tolmezzo (presente in Sotvia nel 1428 e 1438, e sul prato di S. Martino nel 1431), Gasparino di Romano Michis da Tolmezzo (nel 1460 super festo Sancti Martini de Gorto, iuxta dicta ecclesia Sancti Martini, nonché a Cella, Comeglians e Prato Carnico tra il 1467 e il 1474).
Dal 1483 al 1528 è attivo Daniele Vidoni da Cella, «figlio di magistro Nicolò del fu Pietro Vidoni» appartenente a «un’agiata famiglia che da tempo possiede una taverna proprio a Cella». Fino al 1485 «esercita la sua professione rogando nei villaggi vicini, quindi si trasferisce ad Ovaro, un centro sicuramente in fase di espansione, che sin dalla metà del Trecento sembra costituire un importante punto di riferimento per le attività artigianali e commerciali del territorio circostante». Benché alle volte si sposti anche lui nei villaggi vicini egli rogherà principalmente «in casa propria, ad Ovaro, ricevendovi regolarmente i propri clienti: in tal senso, dunque, con Daniele Vidoni verrebbe a delinearsi una figura affatto nuova e moderna rispetto al notariato locale precedente, il cui prestigio sembra anzi avvicinarsi allo status professionale dei notai operanti in ambito urbano.» Muore nel 1529. «Gli succederà qui il figlio Nicolò (1530 - 1561), cui si deve l’estrazione dalle sue imbreviature di un importante concordio riguardante la consegna del crisma alla chiesa di S. Margherita di Sappada, rogato a Cella il 26 giugno 1493.»
Capitolo IV
Il quarto capitolo, intitolato L’edizione delle fonti documentarie, illustra dettagliatamente i 139 documenti editi - 2 dei quali risalenti al XIII secolo, 52 al XIV e 85 al XV (Tabella 2) - dal punto di vista archivistico e storico-documentale. Si tratta in maggioranza di «atti privati, ovvero negozi giuridici riferentisi alla pieve di Gorto o alle sue chiese filiali, che quasi sempre figurano tra le parti contraenti, tuttavia vi sono anche alcuni documenti - in particolare cinque lettere di indulgenza, due concessioni e tre sentenze emanate da autorità religiose minori - che dal punto di vista formale possiamo definire pubblici o semipubblici, essendo prodotti da una cancelleria o, in mancanza di questa, da un notaio appositamente incaricato.»
Dalla loro classificazione «secondo la tipologia giuridica» (Tabella 3) emergono 24 gradazioni diverse, raggruppabili in tre aree:
- prevalgono i “testamenta”, contenenti «sempre, in primo luogo, la disposizione di legati pro remedio anime in favore di una o più chiese». A questi si possono quindi affiancare «le cinque “depositiones testium”, relative a testamenti di cui in precedenza non avevasi scrittura» e «la documentazione relativa ai lasciti in favore delle varie chiese» espressa «in forma di semplici “legata”, il “rotulus plebis Gorti" e varie dichiarazioni - “affirmationes”, “confessiones”, “contentationes", ecc. - atte a garantire il regolare pagamento dei legati» come pure «le quattro “sententiae arbitrariae” e due “sententiae” dell’arcidiacono di Gorto» tutte inereenti a legati testamentari. (per un totale di 75 documenti)
- seguono gli atti relativi alle attività economiche della pieve e delle filali comprendenti «le obbligazioni livellarie (“venditiones livelli") contratte da privati nei confronti di varie chiese, una “francatio livelli", “venditiones” di beni o diritti, e le “venditiones iure livelli”, ovvero transazioni di beni immobili gravati da certi oneri perpetui di cui le stesse chiese risultano essere beneficiarie; meno frequenti sono invece le “livellationes” in senso proprio e le “locationes”, in quanto la pieve e le filiali dispongono di un patrimonio immobiliare piuttosto modesto.» A quest’area appartengo «anche due “donationes” ed uno “scriptum”», «così come due “procurationes” ed una “renunciatio liti” relative a cause per il possesso di beni immobili», nonché «una “finis remissio” non direttamente riferibile ad alcun ente ecclesiastico» probabilmente «in relazione con documenti ora perduti». (55 documenti)
- per concludere con gli atti concernenti la vita religiosa delle chiese, limitata a «cinque “litterae” di indulgenza emanate per diretta volontà del patriarca di Aquileia, o di un suo vicario, riferentisi alle chiese di S. Caterina di Luint …, S. Canciano di Prato Carnico …, S. Maria pieve di Gorto … e S. Leonardo di Osais»; «due “licentiae” dell’abate di Moggio per l’edificazione delle chiese di Osais … e Sostasio», una “sententia” relativa ai rapporti tra la cura di S. Matteo di Ravascletto e le cure di S. Maria di Gorto e S. Giorgio di Comeglians», ratificata dal vicario abbaziale di Moggio …, ed un “concordium” riguardante la consegna del crisma alla chiesa di S. Margherita di Sappada». (9 documenti)
L’esame delle fonti documentarie prosegue, quindi, con l'approfondimento di altri aspetti (scrittura, protocollazione e note, composizione del testo, “stile” compositivo, datazione, signun notarii, problemi connessi all’estrazione dalle imbreviature di altri notai e alla pubblicazione dei documenti, ecc. ), riguardanti in particolare i testamenti, costituenti «la tipologia più frequente tra i documenti esaminati».
Sezione documentaria
Dal punto di vista editoriale, la parte centrale del libro, riservata alle fonti, si presenta molto curata, limpida e chiara.
I documenti sono «disposti e numerati in ordine cronologico»; la trascrizione di ciascuno è preceduta dall’indicazione della «tipologia giuridica» e della data, da un sintetico regesto, dalla descrizione della tipologia archivistica (originale, originale da imbreviatura di altro notaio, copia semplice, copia autentica), dall'indicazione della collocazione archivistica, dalla descrizione del supporto fisico, della scrittura, nonché dai riferimenti alla tradizione manoscritta (costituita da copie principalmente di Giovanni Gortani e Antonio Roia, e regesti del notaio Giovanni Daniele De Prato di Chialina (1761-1797)), e da con un sintetico giudizio sullo stato di conservazione del supporto (si veda l'immagine seguente della pagina n. 95 del libro).

Gli apparati editoriali comprendono ben cinque indici - tre dei quali, l’indice dei nomi di persona, di luogo e delle cose notevoli, particolarmente ampi e articolati - che consentono al lettore di districarsi tra una miriade di elementi spesso anfibiologici e rendono visivamente percepibili la complessità e l’accuratezza del lavoro svolto.
Conclusione
L’utilità e l’efficacia di questi apparati per penetrare un complesso documentario non immediatamente maneggiabile, spiega forse, almeno in parte, la capacità del libro di raggiungere una platea non “specialistica” di lettori.
Su ciò che si può trarre dai documenti, accanto a quanto dimostrato nei capitoli introduttivi dallo stesso Gilberto Dell’Oste, forse può essere utile segnalare l’esperienza di Pietro Cella. Egli definsce le sue Memorie di Givigliana, scritte attingendo anche ai documenti della Pieve di Gorto, come un «umile studio della vita del popolo, che non ha grandi fatti da portare all’ammirazione del pubblico, e si svolge lenta ed oscura, ma potente», manifestandosi «nei costumi e nelle istituzioni, che sono il capolavoro dei paesi, nelle vicende della proprietà, nella fortuna delle famiglie», e per descrivere l’origine di Giviliana ricorre agli antichi documenti in questo modo:
«Nel 1322, ai 13 marzo, un certo Giovanni fu Teudo da Givigliana lasciava, a suffragio dell’anima sua e dei suoi parenti, alla chiesa della Pieve, e alle cappelle di S. Canciano in Prato Carnico e di S. Giacomo in Rigolato tre libre d'olio all’anno, una per ciascuna chiesa, da pagarsi il giorno di Natale, e per ciò vincolava un suo campo situato in Nava di Sotto, nella Tavella di Givigliana, confinando da una parte con Romano di Givigliana. dall'altra con Vecellio anch’esso da Givigliana, e dalla terza parte con la strada pubblica. Il giorno primo di maggio dello stesso anno 1322 un Vecellio fu Gussetto da Givigliana, anch’esso in suffragio dell’anima sua e dei suoi parenti lasciava al lume della chiesa di Pieve di Gorto, a S. Giorgio di Comeglians e a S. Giacomo di Rigolato tre libre d’olio, vincolando un suo campo con prati posto in Val, nella tavella di Givigliana, confinante da una parte con Gusettino, suo fratello. Presenti al contratto sono Giovanni Teudo e Vecellio fu Guarnerio da Givigliana fra vari altri di Ludaria e di Sigilletto.
Eccoci dunque già nel 1322 con un primo gruppo di cinque famiglie, cioè un Giovanni fu Teudo, un Vecellio fu Guarnierio, un Romano, un Vecellio fu Gusetto e Gusettino suo fratello».
Credo che molti lettori, specie se con origini gortane, tra i quali anche il sottoscritto, abbiano seguito, almeno all’inizio, uno stimolo simile nello sfogliare il libro di Gilberto Dell’Oste e si siano ritrovati a sottolineare nomi e località nei vari indici e nei relativi documenti cercando di risvegliare sopite (e remote) nozioni di latino per interpretarli.
In quest’ottica, con l'intento di facilitare una visione “geografica” della distribuzione dei nomi di persona, sperando di rendere un piccolo omaggio al lavoro di Gilberto Dell’Oste, si è prima scomposto il suo indice, per ricomporlo poi - ordinato per zona, comune, località attuali e per documento - in una tabella liberamente scaricabile da questo sito.
Tabelle
- Presentazione di Cesare Scalon (p. 7-8); Sigle e abbreviazioni (p. 9-11); Premessa (p. 13-16).
- Cap. I La pieve di Gorto e le chiese filiali (p. 17-25); Cap. II I sacerdoti e l’arcidiaconato (p. 27-38); Cap. III I notai nel Canal di Gorto (p. 39-48); Cap. IV L’edizione delle fonti documentarie (p. 49-61).
- Carte del vicariato foraneo di Gorto in Carnia (1270-1497) (p. 63-326).
- Segni di tabellionato di alcuni notai carnici (8 p. fuori testo, p. 327).
- Indice dei rogatari dei documenti (p. 331-332); Indice dei nomi di persona (p. 333-347); Indice dei nomi di luogo (p. 348-357); Indice delle cose notevoli (p. 358-362); Indice generale dei documenti (p. 363-366).
| XIII SEC. | XIV SECOLO | XV SECOLO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1 | 1300 | 1 | 1341 | 2 | 1382 | 2 | 1400 | 3 | 1423 | 1 | 1443 | 2 | 1464 | 1 | 1483 | 1 |
| 1295 | 1 | 1305 | 2 | 1342 | 4 | 1387 | 2 | 1404 | 1 | 1426 | 5 | 1444 | 1 | 1467 | 2 | 1485 | 4 |
| 1309 | 1 | 1343 | 1 | 1388 | 2 | 1410 | 1 | 1428 | 1 | 1446 | 1 | 1469 | 2 | 1488 | 1 | ||
| 1316 | 1 | 1344 | 1 | 1389 | 1 | 1412 | 1 | 1430 | 3 | 1447 | 4 | 1471 | 1 | 1489 | 1 | ||
| 1319 | 1 | 1345 | 1 | 1390 | 2 | 1413 | 1 | 1431 | 1 | 1450 | 3 | 1472 | 1 | 1493 | 2 | ||
| 1320 | 1 | 1346 | 2 | 1391 | 2 | 1414 | 2 | 1432 | 2 | 1452 | 1 | 1473 | 2 | 1495 | 1 | ||
| 1323 | 2 | 1348 | 4 | 1394 | 2 | 1415 | 1 | 1433 | 1 | 1457 | 1 | 1474 | 2 | 1496 | 1 | ||
| 1324 | 1 | 1350 | 1 | 1395 | 3 | 1417 | 2 | 1435 | 1 | 1458 | 2 | 1476 | 4 | 1497 | 1 | ||
| 1328 | 1 | 1351 | 1 | 1397 | 1 | 1418 | 2 | 1438 | 1 | 1460 | 1 | 1477 | 1 | ||||
| 1334 | 1 | 1368 | 1 | 1399 | 1 | 1420 | 2 | 1440 | 1 | 1462 | 1 | 1480 | 2 | ||||
| 1338 | 2 | 1370 | 2 | 1421 | 2 | 1442 | 1 | 1463 | 1 | 1481 | 1 | ||||||
| TOT | 2 | TOT | 52 | TOT | 85 | ||||||||||||
| a | Testamenta | 43 | a | Confessiones | 2 | |
| b | Venditiones livelli | 20 | b | Donationes | 2 | |
| b | Venditiones | 16 | c | Licentiae | 2 | |
| a | Legata | 10 | b | Locationes | 2 | |
| b | Venditiones iure livelli | 6 | b | Procurationes | 2 | |
| a | Depositiones testium | 5 | c | Concordium | 1 | |
| c | Litterae | 5 | b | Declaratio et obligatio | 1 | |
| a | Contentationes et promissiones | 4 | b | Finis absolutio | 1 | |
| a | Sententiae arbitrariae | 4 | b | Francatio livelli | 1 | |
| a | Affirmationes et promissiones | 3 | a | Renunciatio liti | 1 | |
| b | Livellationes | 3 | b | Rotulus pblebis Gorti | 1 | |
| a/c | Sententiae | 3 | c | Scriptum | 1 | |
| Legenda: a = “testamenta” e atti connessi; b = atti relativi alle attività economiche delle chiese; c = atti concernenti la vita religiosa delle chiese | ||||||